L’Accademia della Crusca: porre argine all’uso esclusivo dell’inglese nella scienza
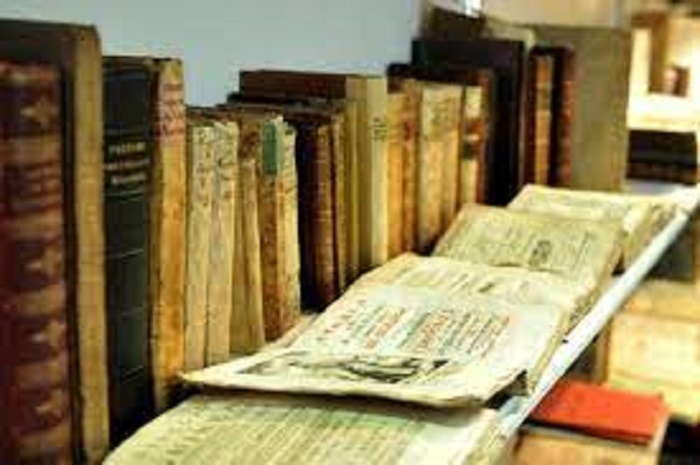
In che modo la lingua inglese, diventata lingua franca della scienza, lascia spazio ad altre lingue? E quanto spazio lascia? Troppo, come pretendono quelli che vorrebbero svalutare l’italiano come una moneta troppo debole in periodo di inflazione? O troppo poco, come lamentano alcuni studiosi? È ancora possibile svolgere ricerca scientifica in italiano e farla apprezzare agli addetti al controllo della qualità del sapere? O resta solo lo spazio della divulgazione? Sono queste alcune delle domande a cui cercherà di rispondere il convegno che l’Accademia della Crusca ha organizzato nella sua sede storica di Firenze. Martedì 28 febbraio, alle ore 14,30 si terrà a Firenze, linguisti e scienziati si confronteranno sul tema “Lingua italiana e scienza, nella stagione di Nature Italy: ripresa reale o fuoco di paglia?”.
C’è il rischio che gli scienziati si disabituino all’italiano
Claudio Marazzini (presidente dell’Accademia della Crusca) coordinerà gli interventi. Al centro dell’attenzione ci sarà il caso “Nature Italy”, una rivista digitale indipendente che parla di ricerca scientifica italiana è accessibile gratuitamente all’indirizzo nature.com/natitaly. Tutti gli articoli sono pubblicati in inglese e italiano. L’Accademia della Crusca intende valorizzare “come merita il peso e il significato” dell’esperimento di “Nature Italy”. Si parlerà, inoltre, di valutazione della ricerca in dipendenza di un giudizio linguistico che spesso condiziona a priori l’esame obiettivo dei contenuti. Molte le domande preoccupate degli accademici della Crusca. “Gli scienziati che hanno abbandonato totalmente l’italiano nel loro lavoro, saranno in grado di divulgare decentemente nella lingua a cui si sono disabituati?
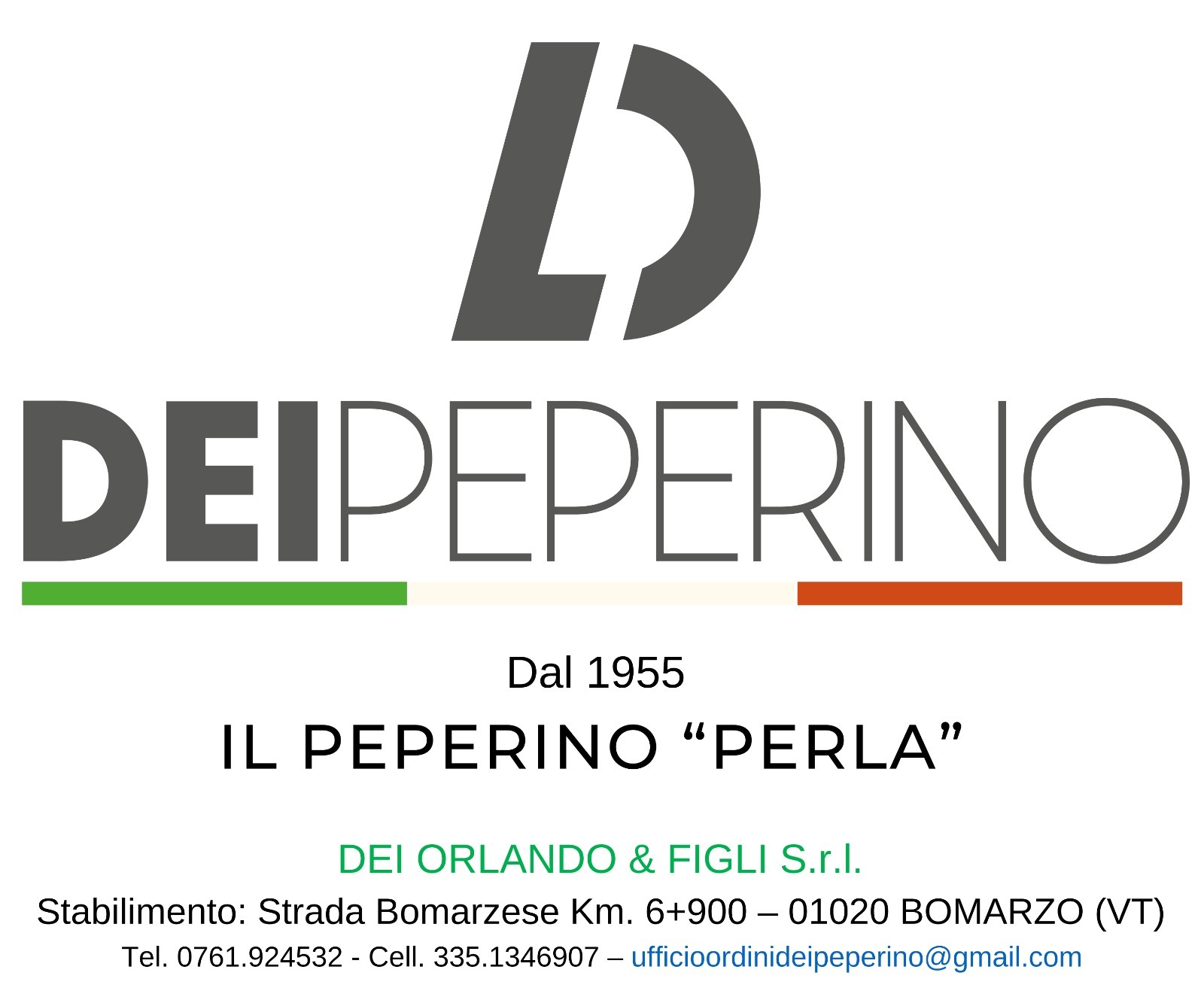
Ci sono discipline che per loro natura usano l’italiano
E poi, quale lingua scegliere, dunque, per veicolare la ricerca, e come valutarne l’impatto nella società? Esiste il rischio di lasciare la gente in balia della falsa informazione? E, quel che è peggio, esiste il rischio di mettere in sottordine e calpestare le discipline che per loro natura usano l’italiano, e devono doverosamente continuare a usarlo. Per esempio per condurre la ricerca sui documenti giuridici, storici, archivistici, artistici e letterari italiani? Ha senso che studiosi che non sanno l’italiano esibiscano bibliografie in cui i documenti primari e fondamentali e specifici, scritti nella nostra lingua, sono palesemente ignorati? Ha senso imporre la priorità dell’inglese in questi settori? Come cambiano codici e stilemi della comunicazione della scienza passando dall’italiano all’inglese e viceversa?”
La Ue ha spinto unicamente verso l’uso dell’inglese
“Il multilinguismo – sperano ancora alcuni ottimisti – dovrebbe avere un peso nella valutazione nazionale della ricerca e del suo impatto. Esistono iniziative internazionali che, almeno nelle intenzioni dichiarate, coinvolgono la variabile del multilinguismo”, osserva il presidente della Crusca, Claudio Marazzini. Ma un importante libro recente, “The Rise of English”, della studiosa di diritto americana Rosemary Salomone (Oxford University Press, 2022), mostra che “tutta la sbandierata politica per il multilinguismo dell’Unione europea ha prodotto una spinta efficace unicamente nella direzione del monolinguismo inglese”. Come giudicare questa tesi della studiosa americana? Sarà eccessivamente pessimistica, o si tratta di una triste verità? Di questo e dei temi connessi, si parlerà al convegno di martedì prossimo.
